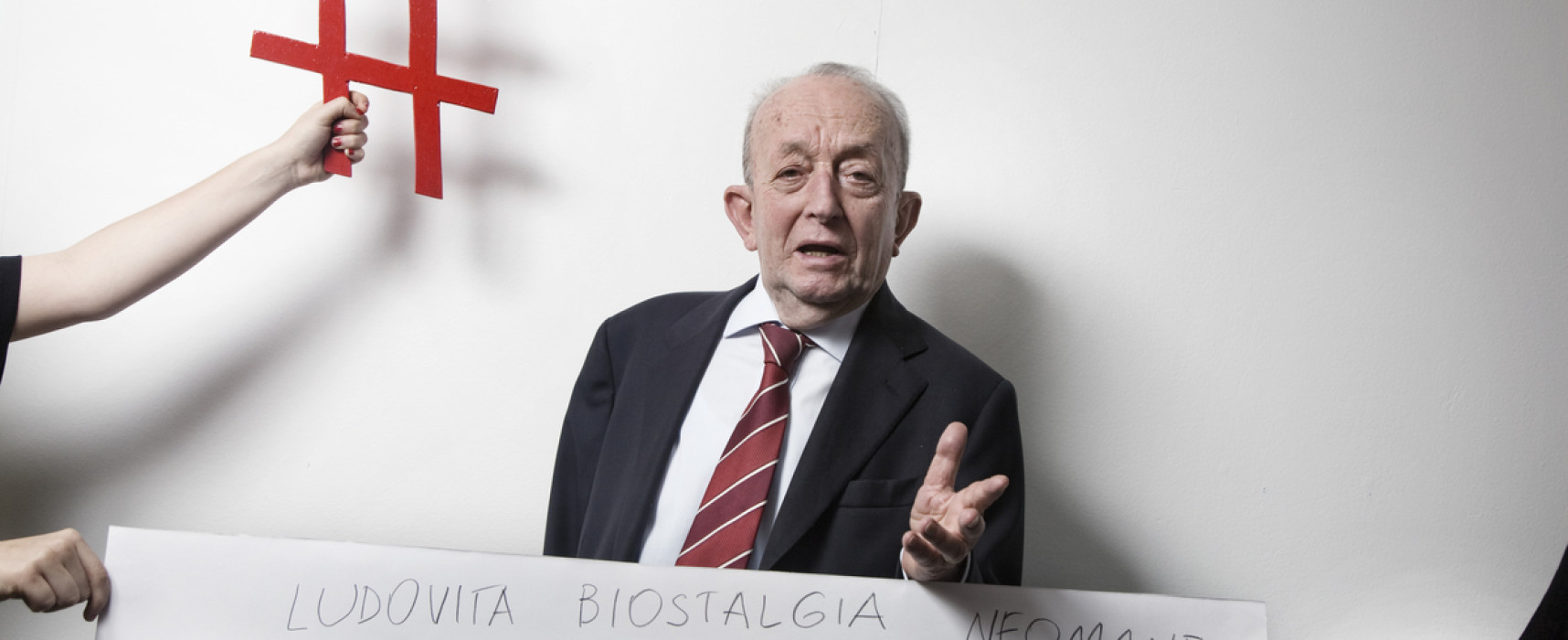Tullio mi manca molto, moltissimo, per mille buoni motivi. Ma li tengo quasi tutti gelosamente conservati dentro di me; per una mia atavica – e certo brutalmente asociale – ritrosia non riesco ad esternare né a condividere i miei sentimenti più profondi.
Però a questo ricordo-di-compleanno non voglio mancare. Richiamo perciò l’attenzione di chi legge su una dote bellissima di Tullio, della quale soffro particolarmente l’assenza: la sua scrittura. Inimitata e inimitabile. Densa, concentrata, ricca ma insieme ariosa, ironica, accattivante; pungente e acre ma insieme amichevole e suadente; tollerante e implacabile, nello stesso tempo serena e tormentata. Acuta e morbida. Preziosa e polifonica. Elegante e semplice. Una tastiera completa, in cui gli elementi dei registri estremi sono coesistenti e quasi sovrapposti, tanto da richiamare costrutti ossimorici.
Si badi solo alla ricchezza dei messaggi contenuti in queste otto righe, nelle quali si concentrano i densissimi contenuti delle Dieci Tesi, uno più dell’altro innovativo, trasgressivo, rivoluzionario, con un di più di rinvii impliciti a un clima culturale acceso, anzi rovente, nel quale si è calata e si cala tuttora ogni idea democratica dell’educazione linguistica. Ebbene: l’animo è forte e impegnato, lo spirito polemico implacabile, ma la prosa è leggera, l’oratoria non è pugnace ma dialettica; e l’analisi critica non si chiude sulla recriminazione ma si apre su obiettivi concreti – ma allo stesso tempo ideali – di impegno lucidamente costruttivo. Una prosa limpida, ricca, variegata, polifonica per il pensiero più lucido, complesso, articolato, immerso nella storia e nell’ideologia.
“Occorre che gli insegnanti lavorino sulle motivazioni a capire ed esprimersi, non meno rilevanti del trapassato remoto, imparino (e imparino gli autori di libri di testo) a misurare pazientemente il noto e l’ignoto lessico grammaticale medio delle varie età per muovere da esso, stimolarne e verificarne l’arricchimento; e occorre definire credibili standard longitudinali. Ancora una volta gioverà ricordare che questa non è una via facilitante per chi insegna e per chi studia. Essa richiede un salto di competenze per gli insegnanti (e per chi presume di poterli formare) e più impegno alle giovani generazioni. Lamentarsi della loro inettitudine e della lingua selvaggia e seguitare in vecchie routine è certamente più facile e trova più ascolto in quello che Gaetano Salvemini chiamava “l’abominevole giornalismo italiano”
(Da Richieste sociali e capacità linguistiche delle giovani generazioni italiane, in M.E. Piemontese (a cura di), i bisogni linguistici delle nove generazioni, La Nuova Italia, Firenze 2000, poi in T.De Mauro, L’educazione linguistica democratica, Laterza, Roma-Bari 2018, p.252)